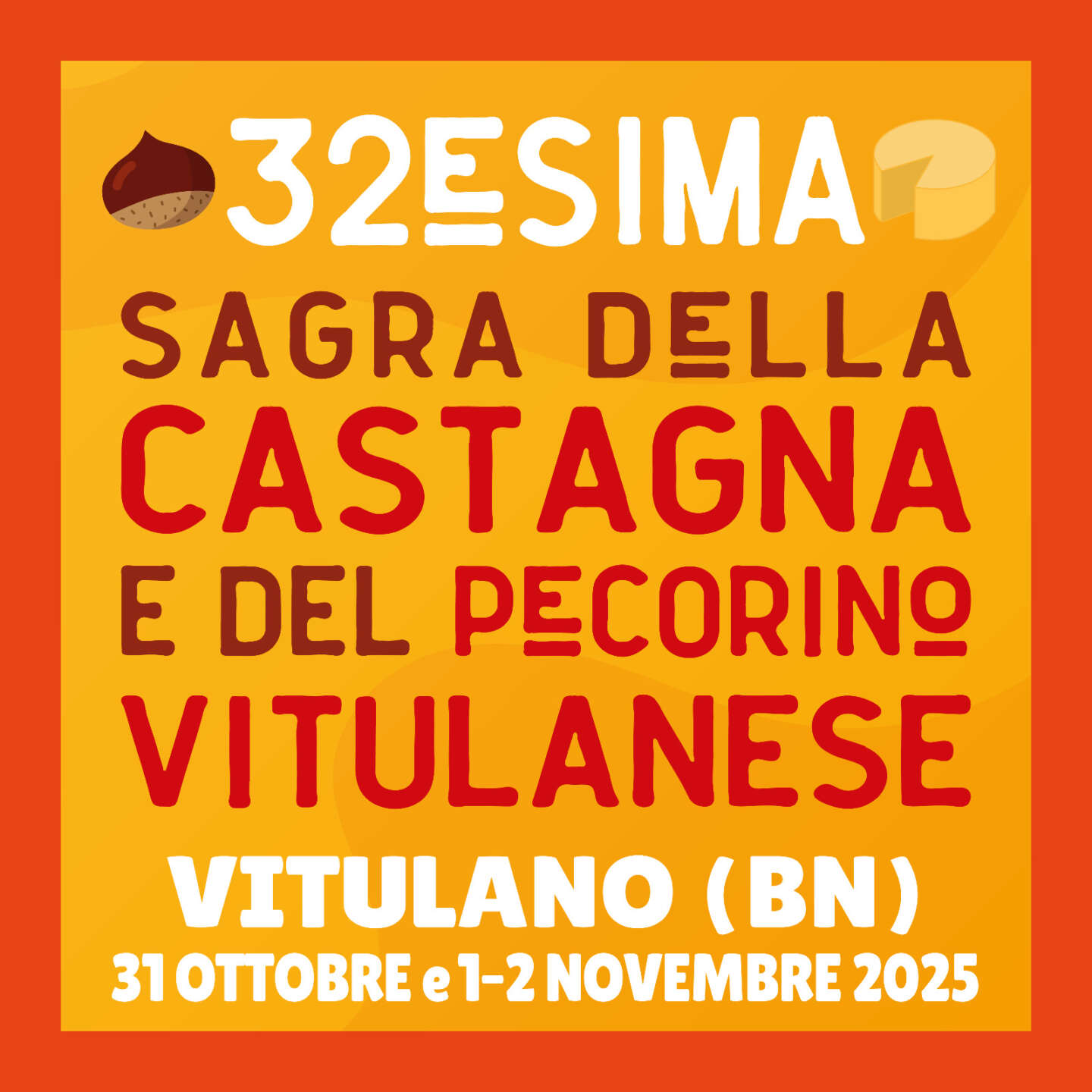Non si arrivava ai livelli delle città medievali come Bologna o San Giminiano, ma anche a Pompei i grandi palazzi delle famiglie emergenti potevano essere dotate di torri, quali simboli del potere e della ricchezza dell’élite locale. È questa l’ipotesi che viene sostenuta in un nuovo articolo “La torre della casa del Tiaso. Un nuovo progetto di ricerca per la documentazione e la ricostruzione digitale della Pompei ‘perduta'”, pubblicato oggi sull’e-journal degli scavi di Pompei https://pompeiisites.org/e-journal-degli-scavi-di-pompei/.
La ricerca si inserisce in un progetto di “archeologia digitale” che mira a ricostruire i piani superiori di Pompei, spesso perduti. Nel caso particolare, gli archeologi guidati dal direttore Gabriel Zuchtriegel e dalla prof.ssa Susanne Muth del Dipartimento di Archeologia Classica dell’Università Humboldt di Berlino (Winckelmann-Institut) in collaborazione con il Parco Archeologico di Pompei, hanno preso spunto da una scala monumentale nella casa del Tiaso che sembra condurre nel nulla. Da lì l’ipotesi che servisse per raggiungere una torre per osservare la città e il golfo, ma anche le stelle di notte, come sono attestate sia nella letteratura (si pensi alla torre di Mecenate da cui Nerone avrebbe osservato l’incendio di Roma), sia nell’arte. Infatti, molti dipinti pompeiani di ville mostrano torri come elemento architettonico. Le ville a loro volta diventano il modello per le case urbane dell’élite. “La ricerca archeologica a Pompei è molto complessa. Oltre a quella sul campo con gli scavi che restituiscono contesti intatti sulla vita nel mondo antico e nuove storie da raccontare sulla tragedia dell’eruzione, esiste anche la ricerca non invasiva, fatta di studio e di ipotesi ricostruttive di ciò che non si è conservato, ma che completa la nostra conoscenza del sito“, spiega dice il direttore del Parco, Gabriel Zuchtriegel. Nel contributo sull’E-Journal oggi pubblicato si presentano i primi risultati di un progetto di ricerca non invasivo, Pompeii Reset, che ha l’obiettivo di utilizzare le tecniche digitali per documentare, in una prima fase ciò che è stato conservato degli edifici sotto forma di modello 3D e, in una seconda fase di ricostruire ciò che è andato perduto sulla base del twin digitale e con l’uso della ricostruzione digitale e della simulazione virtuale. “La ‘Pompei perduta’ consiste soprattutto nei piani superiori, che sono essenziali per comprendere la vita nella città antica. Mettendo insieme i dati in un modello digitale 3D possiamo sviluppare ipotesi ricostruttive che ci aiutano a comprendere l’esperienza, gli spazi e la società dell’epoca.”