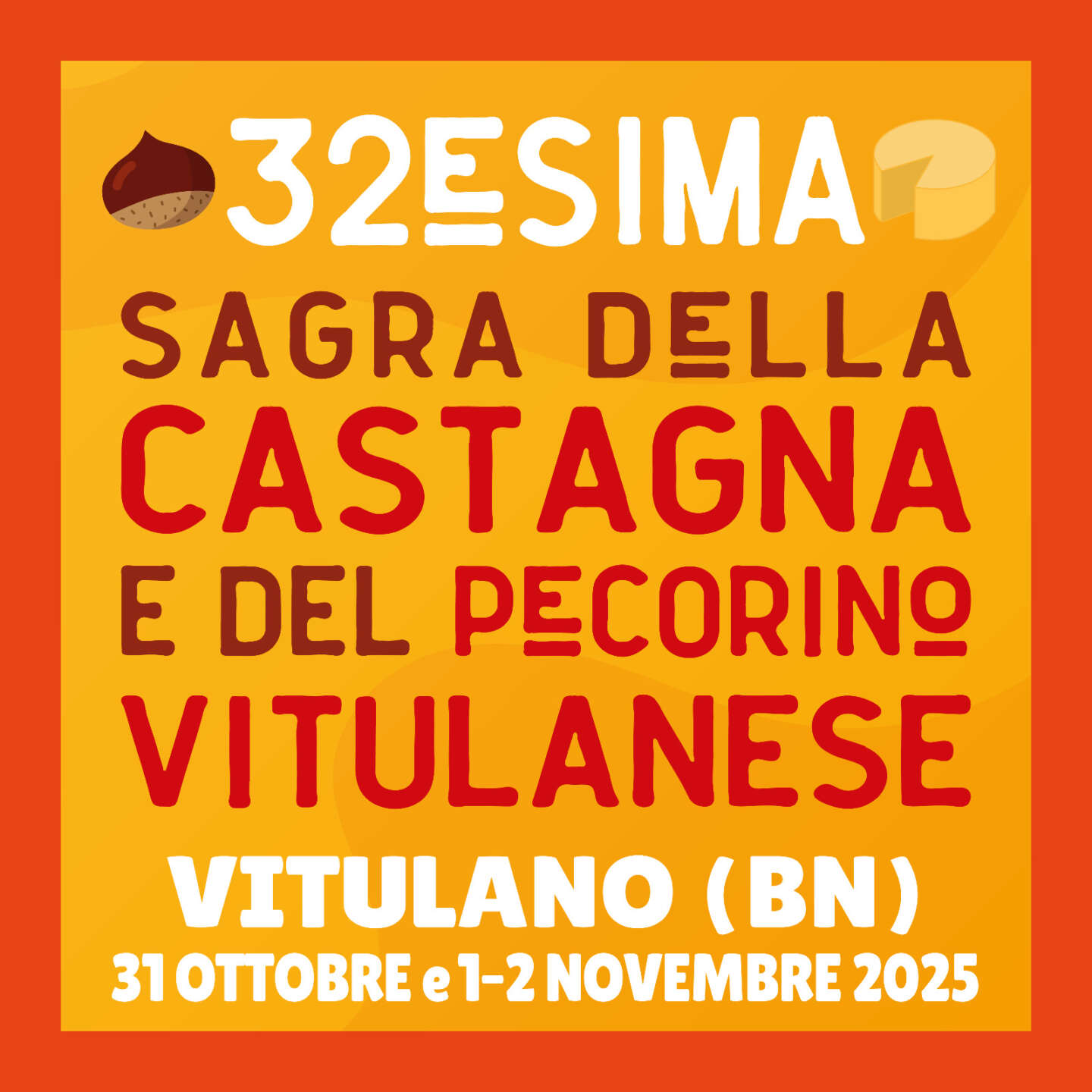Riceviamo e pubblichiamo la nota di Fioravante Bosco, già segretario generale della Uil di Benevento Lo spopolamento delle aree interne è una delle questioni più gravi che minaccia la sostenibilità economica e sociale di molte regioni, in Italia e nel resto del mondo. Nel Sannio, come in molte altre parti d’Italia, la lontananza dai principali centri urbani, la carenza di servizi essenziali e la scarsità di opportunità di lavoro nelle zone rurali sono alla base del progressivo spopolamento che da alcuni decenni affligge queste terre. Esistono soluzioni concrete – mai messe in campo finora -che attraverso un approccio integrato e lungimirante potrebbero invertire questo processo e ridare vitalità alle aree interne. Per metterle in campo è necessaria un’analisi che non si limiti a un semplice dato demografico ma che consideri il Sannio nel suo complesso, e quindi il suo territorio, la sua geografia e la sua storia.
Le cause principali dello spopolamento nelle aree interne sono molteplici. Prima di tutto la crescente urbanizzazione, che attrae le giovani generazioni verso le città in cerca di opportunità di lavoro, studio e vita sociale. Ma anche la carenza di servizi essenziali come sanità, istruzione e trasporti rende difficile la permanenza nelle zone rurali. Inoltre, l’invecchiamento della popolazione nelle aree interne, che registra un indice di vecchiaia significativamente superiore rispetto alle aree urbane, è una delle sfide più difficili da affrontare. Secondo i dati Istat, tra il 2014 e il 2019, le aree interne italiane hanno visto una diminuzione di circa 1,5 milioni di residenti, con il fenomeno dell’invecchiamento che diventa sempre più preoccupante. Difatti, il tasso di invecchiamento nelle aree interne si aggira intorno al 196,2, rispetto al 178,8 delle aree urbane, segno che la mancanza di opportunità contribuisce a un rapido declino.
La conseguenza è che ampie aree del paese risultano meno vivibili per le famiglie, specialmente se hanno figli a carico. Da ciò deriva il progressivo spopolamento che ha caratterizzato i comuni periferici, fin dal dopoguerra.
Dal 1951 a oggi, la popolazione nei comuni polo – baricentrici in termini di servizi – è aumentata del 30,6%: da 15,8 a 20,6 milioni di abitanti. Nei comuni cintura, cioè nell’hinterland delle città maggiori, l’aumento è stato del 48,9% (da 16 a quasi 24 milioni). In quelli periferici e ultraperiferici si è registrato un crollo negli ultimi 70 anni, rispettivamente del 17,7 e del 26,4%. Ovvero, da 6,7 milioni di abitanti censiti agli inizi degli anni ’50, a 5,4 milioni settant’anni dopo.
Il dibattito che si è aperto intorno al tema dello svuotamento delle aree interne è senz’altro inquinato dall’attenzione all’uso del termine “irreversibile” in relazione allo spopolamento di un gruppo di Comuni marginalizzati, in particolare nel Mezzogiorno. L’assenza di politica e di politiche, cioè, innesca e amplifica il problema.
Peraltro, l’Italia è il Paese europeo con la maggiore presenza di aree interne. La Strategia nazionale per le aree interne non ha prodotto fin qui risultati apprezzabili. Occorrerebbe potenziare il welfare e le infrastrutture soprattutto al Sud, e favorire la fusione dei piccoli comuni.
L’Italia è il Paese europeo più dualistico per estensione e persistenza, e quello con la maggiore presenza di aree interne. Le aree interne ospitano oltre il 20% della popolazione italiana e ne fanno parte quasi il 50% dei comuni italiani. L’Italia si è dotata di una Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) solo in tempi recenti, quando si è reso palese il loro spopolamento, a causa delle emigrazioni e della denatalità.
L’intervento a favore delle aree interne ha fondamentalmente due motivazioni: in quei luoghi risiedono prevalentemente anziani, che hanno difficoltà a spostarsi, e che ovviamente dovrebbero godere degli stessi diritti di cittadinanza di chi risiede in città. In secondo luogo, le aree interne italiane sono aree nelle quali si conserva la storia locale, la tradizione gastronomica e si custodisce un rilevante patrimonio paesaggistico, naturale e culturale. In altri termini, le aree interne vanno difese per la riproduzione dell’identità collettiva, contrastando l’omologazione culturale associata alla globalizzazione. Gli esempi più evidenti di omologazione riguardano i fenomeni di “gentrificazione”, ovverossia il concetto sociologico che indica il progressivo cambiamento socioculturale di un’area urbana da proletaria a borghese, a seguito dell’acquisto di immobili, e loro conseguente rivalutazione sul mercato da parte di soggetti abbienti.
C’è anche da considerare un aspetto storico. Le aree periferiche del Mezzogiorno – e ancor più le aree interne meridionali – non hanno mai avuto un’ampia base industriale e, per conseguenza, non hanno storicamente sperimentato lotte operaie e conflitti sociali. Una ragionevole congettura porta a ritenere che questa parte della dimensione storica dei rapporti città-aree interne, nell’esperienza italiana, può dar conto del minore sviluppo economico di queste ultime. Non è casuale il dato per il quale la maggiore crescita economica al Sud si ha e si è avuta nelle città portuali-industriali.
Su questa linea, si possono avanzare – e sono state avanzate – alcune proposte per il rilancio produttivo delle aree interne, e dunque per contrastarne l’abbandono. Si fa qui riferimento a tre assi di intervento. Il primo attiene al potenziamento delle infrastrutture materiali e del sistema dei trasporti. Il secondo riguarda il potenziamento quantitativo della pubblica amministrazione per la fornitura di servizi di welfare e il loro miglioramento qualitativo, con l’obiettivo di agevolare la natalità, di migliorare la qualità della vita della popolazione residente in larga misura anziana, di accrescere la produttività del lavoro tramite fornitura di migliore sanità e migliore istruzione. Il terzo riguarda l’introduzione ope legis di normative che impongano la fusione dei comuni, per realizzare, contestualmente, economie di scala e accelerazione dei tempi di decisione.
Nel primo caso, come è noto, vi sono ampi margini di miglioramento sul piano qualitativo e di potenziamento quantitativo dell’infrastrutturazione materiale italiana, e soprattutto meridionale. Si stima, a riguardo, che solo una regione meridionale su 8 (la Campania) è collocata fra le prime 100 regioni europee per competitività infrastrutturale.
Il secondo problema è collegato al notevole sottodimensionamento della Pubblica Amministrazione italiana, e ancor più meridionale, quantificato come rapporto fra numero di dipendenti pubblici e residenti. La PA italiana è attualmente quella con il perimetro più ristretto fra i principali Paesi europei, con i salari più bassi per i suoi dipendenti e con la più elevata età media che è di circa 60 anni!
Il terzo problema riguarda l’elevata frammentazione istituzionale, dunque l’esistenza notevole di comuni, ciascuno dei quali è troppo piccolo. La fusione dei comuni potrebbe portare benefici in considerazione dei seguenti effetti. In primo luogo, si produrrebbe riduzione dei costi per gli enti locali attraverso l’unificazione delle strutture amministrative e la soppressione della duplicazione degli uffici comunali; in secondo luogo, si determinerebbero economie di scala nella gestione amministrativa nelle aree interne. La teoria economica e l’esperienza amministrativa stabiliscono, a tal riguardo, un principio di ordine generale: il grado di divisione del lavoro, e dunque la specializzazione dei lavoratori, sale con l’aumentare delle dimensioni dell’unità produttiva, implicando maggiore efficienza amministrativa.
Vi sarebbe ancora il tempo per ripensare a una struttura dello Stato e delle sue diramazioni costituzionali più leggera ed efficiente, magari togliendo la gestione delle risorse alle regioni a trasferendole alle province, che potrebbero meglio intervenire sul territorio per far fronte alle effettive esigenze dei cittadini. Sembra utopia rispetto a ciò che è stato fatto sinora, ma secondo me è la sola strada che possa aggiustare i conti dello Stato e dare una speranza di salvezza alle piccole realtà, specialmente nel Mezzogiorno d’Italia.
Abolire le province e accorpare le prefetture, nel tragicomico disegno di Matteo Renzi – che sebbene avesse annunciato le sue dimissioni in caso di sconfitta al referendum del 4 dicembre 2016, ancora non è scomparso dall’agone della politica politicante – sarebbe stata per il Sannio una ”botta” definitiva verso un’inarrestabile deriva. Difatti, abolire il collante del territorio, che è rappresentato dalle provincie, avrebbe ancor di più portato i piccoli comuni a soffrirne le conseguenze. Nel frattempo la legge Delrio, la n. 56 del 7 aprile 2014, aveva trasformato le province in enti di secondo livello, massacrando così le comunità locali, poiché questi enti sono stati disarticolati con la riduzione delle poche risorse disponibili.
Quanto all’accorpamento delle prefetture, se fosse stata realmente realizzata, Benevento avrebbe subito perso la questura e il comando provinciale dei vigili del fuoco, ma successivamente sarebbero andati via tutti gli uffici periferici dello Stato, processo che nonostante il referendum e il ripensamento legislativo sta comunque procedendo. Infatti, le direzioni di Camera di commercio, Inail, Ragioneria Territoriale dello Stato, Ispettorato del Lavoro, Genio Civile, sono già state dirottate ad Avellino. Questo produrrà in prospettiva un’ulteriore perdita di posti di lavoro a Benevento, poiché una cosa è avere sul territorio un ente statale che agisce autonomamente, altro è essere sede secondaria, e solo per adesso, distaccata di Avellino.
Quanto alle risorse del PNRR e al concetto che da esse possa derivare un impatto economico e sociale duraturo, non basta abbattere le scuole e ricostruirle, ma probabilmente bisognava creare nuove infrastrutture per favorire l’occupazione giovanile, creando un circolo virtuoso di sviluppo economico. Anche perché l’emigrazione e la denatalità non promettono nulla di buono rispetto alla certezza che nel futuro le nuove strutture scolastiche possano essere completamente utilizzate.
Chiudo sostenendo che abbiamo due splendide realtà: l’Università degli Studi del Sannio e il Conservatorio Statale di Musica, che continuano a crescere in qualità ed efficienza nel panorama nazionale di questi importantissimi enti di formazione universitaria e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.
(foto di repertorio)