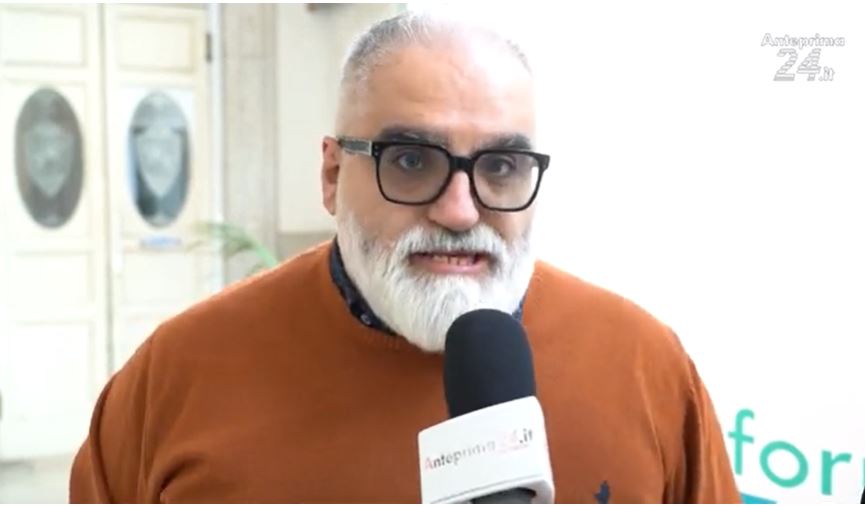Il nuovo disegno di legge regionale sulle cave e le estrazioni dai fiumi non è una norma “tecnica”: è una scelta politica che riguarda il futuro dei nostri territori. Infatti dietro la promessa di sicurezza idraulica e riqualificazione, il testo apre la porta alla vendita di sabbia e ghiaia fluviale, a garanzie economiche dimezzate per il recupero delle cave e a deroghe che permettono nuove aperture in aree fragili. Tradotto: più cave, più estrazioni, meno tutele per fiumi, coste e paesaggi.
Questo è quanto contenuto nel disegno di legge regionale “Disposizioni in materia di estrazioni dai corsi d’acqua, riqualificazione delle cave e contributi e polizze per attività estrattiva”, che modifica la storica legge 54 del 1985 sulle attività estrattive in Campania. Alla vigilia delle elezioni di novembre, la Giunta regionale porta in aula un disegno di legge che modifica la normativa sulle cave e introduce nuove regole per le estrazioni dai corsi d’acqua. Il titolo promette “riqualificazione” e “sicurezza idraulica”, ma il contenuto solleva più di un allarme: sembra più un provvedimento di fine mandato che un atto di visione a lungo termine. Il DDL consente di asportare sabbia e ghiaia dai fiumi per migliorare il deflusso delle acque, ma prevede che il materiale in esubero possa essere ceduto anche a titolo oneroso. Una porta spalancata alla commercializzazione dei sedimenti fluviali, con il rischio di alterare irreversibilmente gli equilibri degli alvei.. E allora perché non prevedere un divieto esplicito, salvo eccezioni giustificate da VIA (obbligatoria sopra una certa soglia) e bilancio sedimentario?
Si legge altresì nel testo del DDL che le garanzie finanziarie richieste alle imprese coprono solo il 50% dei costi di ripristino ambientale: troppo poco per evitare che, alla fine, i cittadini paghino il conto. Perché non una copertura al 100% + 20% per contingenze, vincolata fino al collaudo ambientale? Le deroghe transitorie e le delocalizzazioni, presenti nel testo del DDL, rischiano di tradursi in nuove cave “mascherate”, senza adeguati vincoli paesaggistici o idrogeologici. Quali motivi hanno impedito di prevedere limiti volumetrici chiari, divieto in aree protette o fragili e consultazione pubblica obbligatoria? Le uniche voci che si sono alzate in questi giorni sono quelle delle associazioni ambientaliste di Legambiente e WWF. Ma guai a pensare che tutto questo non riguardi il Sannio. I dati pubblicati da Confindustria Benevento sono impietosi. La lunga galleria idraulica Campolattaro-Ponte a valle dell’invaso sul fiume Tammaro prevede un fabbisogno estrattivo di 1.300.000 mc, che se sommato ad altre opere che interessano il Sannio come i lavori AV/AC Napoli-Bari, l’ANAS telesina + fortorina, l’asse attrezzato Valle caudina-Pianodardine e vari interventi dell’Alto Tammaro totalizzano una necessità di circa 10.350.000 mc di materiale da cava.
Insomma, un tempismo discutibile. Colpisce soprattutto il contesto politico: perché presentare un disegno di legge così delicato alla vigilia del voto? La sensazione è che, sotto il vessillo della sicurezza idraulica e del recupero delle cave, si voglia accelerare per garantire nuove opportunità agli operatori del settore, lasciando al futuro Consiglio il compito di gestirne le conseguenze ambientali. Chi governa oggi ha il dovere di non scaricare sul domani i costi ambientali di scelte affrettate. Il DDL può ancora essere corretto con emendamenti mirati che bilancino interessi economici e tutela del territorio. Diversamente, rischia di passare alla storia non come una legge di riqualificazione e sicurezza ambientale, ma come l’ultimo scavo di fine legislatura.